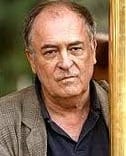di Giuseppe Bertolucci www.espressonline.it
Sono testi scritti per essere detti, cose, appunto, da dire: riflessioni sulla poesia, sul cinema, sulla psicanalisi, ritratti dell’attore da cucciolo (Benigni) o del Patriarca del cinema italiano (Zavattini), un dialogo con l’opera di Pasolini ("L’uomo che sapeva troppo"). Un caleidoscopio di punti di vista apparentemente sconclusionato, che però, a una lettura più attenta, rivela i contorni di un tema persistente nel tempo, quello – in estrema sintesi – del rapporto tra letteratura e cinema, tra parola e immagine riprodotta. È lì che ho giocato la mia partita creativa di autore (di giovanissimo poeta, teatrante e cineasta), ma è soprattutto lì che si sta giocando una partita decisiva per le sorti della nostra civiltà, quella tra la scrittura e la riproducibilità tecnica delle immagini, due modalità diverse di espressione e di comunicazione che hanno attraversato il Ventesimo secolo in apparente concordia, ma che all’alba del Terzo millennio rivelano la loro opposta, forse inconciliabile, natura e vocazione. Non a caso il libro si apre con uno scritto intitolato "Una vita in versi" e si chiude con "Le derive della riproducibilità". Il primo è una riflessione sulle poesie di mio padre dedicate a me: la peculiarità di queste considerazioni è che appartengono, pirandellianamente, a un personaggio (che sarei io), "scritto" da un poeta e che, per una volta, prende la parola esprimendo le ragioni del proprio vissuto, spesso confliggendo con la magnifica sovranità creativa dell’autore che l’ha raccontato e per così dire "inventato dal vero". La testimonianza di questa così estrema lettura, in continua alternanza tra gratificazione, gratitudine, inquietudine e ostilità è forse il momento più inconsueto del libro. Ed è tutto incentrato sulla scrittura, sulla parola, e su quella magnifica intuizione di Ferdinand de Saussure – l’arbitrarietà del segno – sulla quale si regge la lingua: il fatto che la parola albero non abbia alcuna relazione con l’oggetto albero è, io credo, uno dei più portentosi "balzi in avanti" della storia dell’umanità.
Nell’ultimo capitolo invece, sotto il segno delle derive della riproducibilità, cerco di ragionare sul come, quanto e perché lo straordinario strumento della "riproducibilità tecnica delle immagini", motore della modernità, si sia trasformato nel corso di un secolo in una trappola, una forca caudina sotto la quale tutto deve passare per assumere una patente di realtà. Insomma il passaggio dalla mirabile conquista dell’arbitrarietà del segno alla disarmante semplificazione della civiltà delle immagini mi sembra che avvenga sotto il segno di una sorta di Grande Regressione, ultimo atto di quel disagio della civiltà che Freud aveva analizzato e denunciato negli anni Trenta. Da queste considerazioni, come dagli allarmi inascoltati di Pasolini, ma soprattutto dalla mia pratica di cineasta, che si è misurato nel corso degli anni con l’immenso e inarrestabile processo dell’omologazione culturale, è andata maturando in me una tentazione inconfessabile di iconoclastia, di odio per le immagini tecnicamente riprodotte, che intrattengono (perseguitano) la nostra vita, in ogni momento e in ogni luogo. Io, per esempio, non sopporto gli schermi piatti, gravidi di pubblicità, che invadono i marciapiedi delle stazioni, i bar e i negozi, produttori di un subdolo e inquinante rumore di fondo. Con una fionda li manderei tutti in frantumi, come il Monello di Chaplin. E poi dal fondo dell’anima mi sale un grido: "Torniamo alla parola! Torniamo alla meravigliosa musica dei versi! Rompiamo la gigantesca specchiera della riproducibilità, che ci imprigiona e ci paralizza in un’autoreferenzialità senza scampo! Torniamo al teatro, alla danza, allo spettacolo dal vivo, spezziamo le insopportabili catene della serialità televisiva…". Ma poi, ritornato in me, ripenso alle reliquie del cinema delle origini, ai grandi Maestri, come Griffith o Ford, che inventarono la lingua del cinema, al mare di emozioni che quel nuovo linguaggio ha regalato a miliardi di persone in poco più di cento anni, penso anche al mio ruolo di presidente di una Cineteca, che dedica tutte le sue energie, le sue competenze e le sue risorse al recupero e alla nuova vita delle opere del passato e quel grido mi muore in gola.