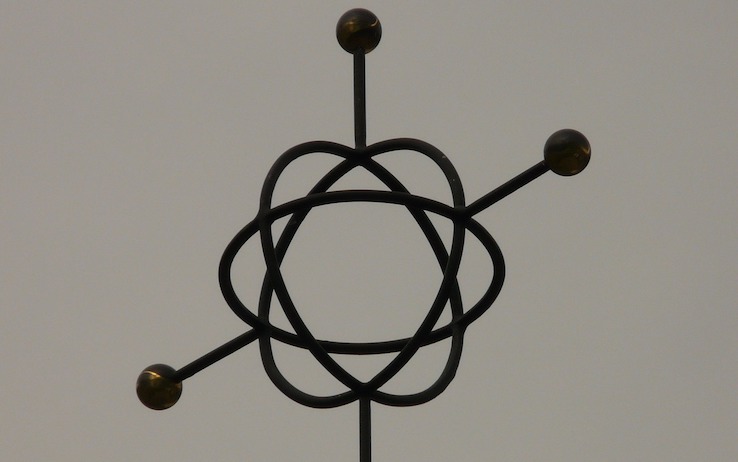Indice degli argomenti
IL NUCLEARE SICURO NON ESISTE
Il contagioso entusiasmo con il quale è stata accolta, anche in Italia e senza troppi approfondimenti, la notizia della fusione nucleare realizzata dai ricercatori americani, dimostra ancora una volta quanta demagogia e ignoranza, entrambe avvolte nelle nubi della malafede, circolino attorno a questo argomento.
FUSIONE NUCLEARE
Per il momento i ricercatori sono riusciti a fondere due nuclei di idrogeno per crearne uno di elio, ricavando più energia di quella usata nel processo. La notizia è ottima, con prospettive per il futuro molto incoraggianti, e con opportunità ancora tutte da decifrare. Ma da qui a dire che, grazie a questa scoperta, avremo il nucleare pulito e sicuro che risolverà i problemi strutturali dei rifornimenti energetici e farà uscire il mondo dalla dipendenza dal carbone e dal petrolio, il passo non è affatto breve. E anzi, facendo confusione si rischia solo di creare false speranze e di alimentare fake news.
LEGGI ANCHE: Ritorno al nucleare: ma dove vive Cingolani?
FUSIONE NUCLEARE VANTAGGI E SVANTAGGI
Sicuramente questa tecnologia appena scoperta, e quindi ancora in una fase embrionale di ricerca e sviluppo, consente di produrre pochi residui radioattivi, non emette gas serra e azzera i rischi di incidenti, quelli che più spaventano le pubbliche opinioni quando si parla di nucleare. Ma i vantaggi di questo presunto miracolo che oggi possiamo considerare sicuri e spendibili per il cambio di paradigma energetico, finiscono qui. E semmai iniziano altri interrogativi che al momento non hanno alcuna risposta certa e rassicurante.
FUSIONE NUCLEARE E CRISI CLIMATICA
Il primo problema riguarda i tempi. Serviranno decenni, e lo dicono gli stessi autori della scoperta, prima che la nuova fusione nucleare possa tradursi in una produzione su larga scala di energia, in modo sicuro e affidabile. Decenni. E invece il mondo deve fare i conti con scadenze ben più ravvicinate. Per limitare l’aumento delle temperature globali a 1,5 gradi, obiettivo minimo per non essere travolti dalla crisi climatica, entro il 2030, le emissioni totali di anidride carbonica dovrebbero essere dimezzate entro il 2019 e quelle nette dovrebbero azzerarsi entro il 2050. Anche un bambino capisce che questi tempi sono incompatibili con l’eventuale progresso della fusione nucleare e della sua ricaduta a cascata sulla produzione energetica su scala mondiale.
FINANZIAMENTI PER FUSIONE NUCLEARE
Un secondo aspetto critico che dovrebbe mettere a tacere i cantori a buon mercato del salvifico nucleare, è il tema dei costi. Enormi. Non possiamo certo immaginare che i progressi sulla fusione nucleare più sicura e senza emissioni siano tutti a carico degli Statu Uniti. E se vogliamo stare in partita, dobbiamo mettere mano al portafoglio. Cosa che la Commissione europea ha già fatto in modo discutibile e poco trasparente: 5,6 miliardi di euro della spesa complessiva per la protezione del clima sono stati destinati alla ricerca sulla fusione nucleare. E sono stati così sottratti ad altri ambiti, per esempio gli incentivi alle rinnovabili. Tutto ciò è conveniente per noi europei? O rischiamo soltanto di sprecare soldi, e tanti?
FUSIONE NUCLEARE E REFERENDUM
Infine, per noi italiani c’è una questione molto delicata ma altrettanto chiara. Il nucleare è stato bocciato due volte, e con un voto a larghissima maggioranza, da due referendum popolari. Gli italiani non vogliono il nucleare. Punto. E non ci sarà mai un governo così autolesionista da sfidare l’opinione pubblica e riaprire davvero, al di là di qualche fumoso annuncio o auspicio, il capitolo del nucleare. Una scelta del genere segnerebbe la sua fine, e ciò significa che il nucleare in Italia è un discorso archiviato. Al momento, per sempre.
QUANTO COSTA UNA CENTRALE NUCLEARE
CENTRALI NUCLEARI DA SMANTELLARE
Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere sempre aggiornato. Clicca qui!
ENERGIA GREEN:
- L’isola Giannutri grazie al fotovoltaico raggiunge l’autosufficienza green
- San Lorenzo Bellizzi: in Calabria, il paese dove i cittadini, grazie al fotovoltaico, non pagano la Tasi
- California green, dal 2020 solo pannelli solari per tutte le nuove case. Si punta sul fotovoltaico
Vuoi conoscere una selezione delle nostre notizie?
- Iscriviti alla nostra Newsletter cliccando qui;
- Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite;
- Seguici su Facebook, Instagram e Pinterest.